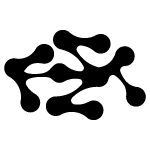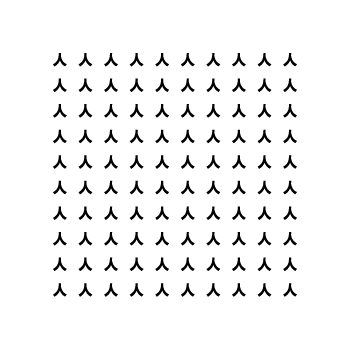Quasi ogni giorno andavo da loro, persone
che, ora, per un motivo o per un altro, non vedo più.
Abitavano sopra una piccola impresa di pompe funebri,
le tende sempre tirate erano nere. Percorrevo
strade dove incrociavo altri come me. Mi guardavano
per farmi capire di essere guardato. Non era un problema,
me lo ripeteva sempre mio padre, l’importante è non
fermarsi mai. Io non ho mai conosciuto qualcuno,
dentro a questa vita di strade, che abbia avuto fortuna
o privilegio di farsi una sosta, di frenare la rivoluzione
incombente del pianeta anche se solo per un istante.
Nell’ultimo periodo della mia permanenza andavo da loro
con maggiore frequenza. Erano tutti più grandi di me
ma ognuno di noi faceva parte del progetto,
un cubetto di lego, si sarebbe potuto dire, della stessa rovina;
questo era sufficiente ad avvicinarci. Ci divideva
un tavolo verdastro, l’ultima notte che ho passato in loro
compagnia. Abbiamo giocato a poker i nostri ultimi soldi,
nessuno aveva la forza di dire basta. Parlavamo di tante cose
e tra queste della vecchia che abitava in quella casa
prima che ci andassero loro. Quella casa al primo piano,
sopra all’impresa di pompe funebri. Parlavamo dei pesanti
mobili di legno inscurito dal tempo, i vecchi mobili
che la vecchia non si era portata nella tomba. Alla fine
si lascia tutto da questa parte perché in paradiso
l’appartamento ti viene assegnato, non puoi scegliertelo,
e non ci sono nemmeno le torri di marzapane né i fiumi
di latte e miele che mia nonna mi descriveva quando,
da bambino, avevo la febbre. La vecchia, come in un racconto
di Stevenson, nelle notti d’inverno raschia la pancia del solaio.
I ragazzi si sono abituati a quella compagnia,
così, quando sentono lo scalpiccio dello spettro
per loro è come dormire sottocoperta, cullati nel mare
delle Antille. Il dolore è qualcosa di elastico, questo
è il problema. Abbiamo bevuto vodka secca, l’ultima volta
che sono stato da loro. Vodka secca portata
dalla Cecoslovacchia. Con succo di albicocca
e un po’ di ghiaccio. Ma in quei giorni faceva troppo caldo
per il ghiaccio, si scioglieva nel bicchiere
come burro in una minestra, lasciava una leggera patina
di cloro cangiante – nella luce al neon.
Quella notte è passata in fretta e ho vinto la partita a poker,
il mattino è rotolato fuori da un punto imprecisato del cielo.
È caduto sulla città senza fare rumore. Quando
mi torna in mente quel periodo della mia vita
penso che tutto stia nell’elasticità di esserci, di esserci a metà
e di non esserci del tutto, come stare in bilico sul trampolino,
da questa parte, quasi da un’altra parte, allo stesso tempo.
che, ora, per un motivo o per un altro, non vedo più.
Abitavano sopra una piccola impresa di pompe funebri,
le tende sempre tirate erano nere. Percorrevo
strade dove incrociavo altri come me. Mi guardavano
per farmi capire di essere guardato. Non era un problema,
me lo ripeteva sempre mio padre, l’importante è non
fermarsi mai. Io non ho mai conosciuto qualcuno,
dentro a questa vita di strade, che abbia avuto fortuna
o privilegio di farsi una sosta, di frenare la rivoluzione
incombente del pianeta anche se solo per un istante.
Nell’ultimo periodo della mia permanenza andavo da loro
con maggiore frequenza. Erano tutti più grandi di me
ma ognuno di noi faceva parte del progetto,
un cubetto di lego, si sarebbe potuto dire, della stessa rovina;
questo era sufficiente ad avvicinarci. Ci divideva
un tavolo verdastro, l’ultima notte che ho passato in loro
compagnia. Abbiamo giocato a poker i nostri ultimi soldi,
nessuno aveva la forza di dire basta. Parlavamo di tante cose
e tra queste della vecchia che abitava in quella casa
prima che ci andassero loro. Quella casa al primo piano,
sopra all’impresa di pompe funebri. Parlavamo dei pesanti
mobili di legno inscurito dal tempo, i vecchi mobili
che la vecchia non si era portata nella tomba. Alla fine
si lascia tutto da questa parte perché in paradiso
l’appartamento ti viene assegnato, non puoi scegliertelo,
e non ci sono nemmeno le torri di marzapane né i fiumi
di latte e miele che mia nonna mi descriveva quando,
da bambino, avevo la febbre. La vecchia, come in un racconto
di Stevenson, nelle notti d’inverno raschia la pancia del solaio.
I ragazzi si sono abituati a quella compagnia,
così, quando sentono lo scalpiccio dello spettro
per loro è come dormire sottocoperta, cullati nel mare
delle Antille. Il dolore è qualcosa di elastico, questo
è il problema. Abbiamo bevuto vodka secca, l’ultima volta
che sono stato da loro. Vodka secca portata
dalla Cecoslovacchia. Con succo di albicocca
e un po’ di ghiaccio. Ma in quei giorni faceva troppo caldo
per il ghiaccio, si scioglieva nel bicchiere
come burro in una minestra, lasciava una leggera patina
di cloro cangiante – nella luce al neon.
Quella notte è passata in fretta e ho vinto la partita a poker,
il mattino è rotolato fuori da un punto imprecisato del cielo.
È caduto sulla città senza fare rumore. Quando
mi torna in mente quel periodo della mia vita
penso che tutto stia nell’elasticità di esserci, di esserci a metà
e di non esserci del tutto, come stare in bilico sul trampolino,
da questa parte, quasi da un’altra parte, allo stesso tempo.