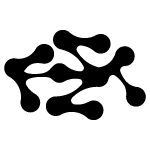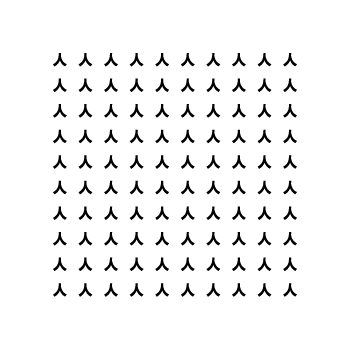ESORCISMO
Ci sono stati periodi in cui appoggiavi la testa
sul mio petto, pomeriggi assolati nel lento inverno
di città. Stavi così e piangevi come un’annegata.
Io ti accarezzavo le guance. E ti dicevo di non
pensarci, perché tutto si sarebbe messo a posto.
Mi raccontavi, ma la tua voce era quasi silenzio,
che certe cose non sono capaci di attendere.
La tua era una vita a testa ingiù. Almeno noi due
siamo noi due, replicava il me di quei giorni. Poi,
quelle stesse tue parole ti conducevano alla quiete
di un sonno inquieto. Dopo un po’ appoggiavo
il libro al tuo fianco e ti scostavo. Ti scostavo piano
così da non svegliarti. Raggiungevo il sentiero,
il sentiero quasi invisibile, il sentiero che insegue
la strada ferrata fino agli incolti. Lo misuravo
nei passi – ogni volta che ci andavo. Trecento, trecento
e ventuno, duecento e cinquanta quattro. Ma le finestre
delle fabbriche, e delle case nere – come tizzoni
spenti – aspettavano là, ogni volta, nello stesso numero.
C’era, davanti al sottopassaggio, un vecchio fusto,
un vecchio fusto di ferro – qualche volta
mi fermavo davanti a lui e ci facevo a botte.
Era un buon avversario, uno di quelli che non
si lamentano e stringono i denti. Ogni fibra
del mio essere riverberava – quasi io stessi percuotendo
il timpano del pianeta. Ero, a quel modo, sollevato
dal mondo – potevo sentire il vento sulla pelle,
il vento che in giornate come questa sgombra il cielo
di ogni fardello. E nella città decide delle
nuove distanze di ghiaccio – oggi, ciò che ci è chiaro
è ciò che ci è lontano. Hai ragione, mi dicevo, non
c’è scampo. Tornavo a casa ripetendomi che sempre
lo inseguiamo. È il lavoro – il lavoro che va
da una parte all’altra, senza dirci niente.
Vorrei che andassimo assieme nel luogo dove il Bounty
condusse uno scampolo di umanità. Si chiama Pitcairn,
ed è solo una voglia tra le scapole dell’Oceano Pacifico.
Potremo starcene su quell’isola per un po’, o per sempre.
La grigliata di pesce ti è sempre piaciuta parecchio
e hai sempre detto che la faccio bene.
Qualcuno dei nostri amici prima o poi ci raggiungerebbe,
di questo stanne certa. E allora saremmo
in buona compagnia – per attraversare il territorio
della vita. Il pomeriggio il cielo si stenderebbe come
una vela e noi ci schiacceremo nell’erba allo stesso modo
dei rospi che prendevi con il retino quando
eri bambina. Il mare farebbe i suoi esercizi
di stretching davanti ai nostri occhi e, dopo
essersi infranto, tornerebbe lo stesso di sempre.
La mansuetudine trarrebbe un nodo solo
dai lacci delle nostre scarpe e a quel modo
ci farebbe inciampare, ci ricorderebbe la vita
con un trascurabile dolore. Potremmo starcene laggiù,
quasi al di là di tutto, sarebbero anni più felici
che tristi. E di quel tuo pianto rimarrebbe l’estemporaneo
getto dell’ombra, una maschera qualche volta
affiorerebbe dai flutti, mutevoli, fuori
da questa baia, e sarebbe inafferrabile
per i becchi dei grandi rapaci oceanici.
Ci sono stati periodi in cui appoggiavi la testa
sul mio petto, pomeriggi assolati nel lento inverno
di città. Stavi così e piangevi come un’annegata.
Io ti accarezzavo le guance. E ti dicevo di non
pensarci, perché tutto si sarebbe messo a posto.
Mi raccontavi, ma la tua voce era quasi silenzio,
che certe cose non sono capaci di attendere.
La tua era una vita a testa ingiù. Almeno noi due
siamo noi due, replicava il me di quei giorni. Poi,
quelle stesse tue parole ti conducevano alla quiete
di un sonno inquieto. Dopo un po’ appoggiavo
il libro al tuo fianco e ti scostavo. Ti scostavo piano
così da non svegliarti. Raggiungevo il sentiero,
il sentiero quasi invisibile, il sentiero che insegue
la strada ferrata fino agli incolti. Lo misuravo
nei passi – ogni volta che ci andavo. Trecento, trecento
e ventuno, duecento e cinquanta quattro. Ma le finestre
delle fabbriche, e delle case nere – come tizzoni
spenti – aspettavano là, ogni volta, nello stesso numero.
C’era, davanti al sottopassaggio, un vecchio fusto,
un vecchio fusto di ferro – qualche volta
mi fermavo davanti a lui e ci facevo a botte.
Era un buon avversario, uno di quelli che non
si lamentano e stringono i denti. Ogni fibra
del mio essere riverberava – quasi io stessi percuotendo
il timpano del pianeta. Ero, a quel modo, sollevato
dal mondo – potevo sentire il vento sulla pelle,
il vento che in giornate come questa sgombra il cielo
di ogni fardello. E nella città decide delle
nuove distanze di ghiaccio – oggi, ciò che ci è chiaro
è ciò che ci è lontano. Hai ragione, mi dicevo, non
c’è scampo. Tornavo a casa ripetendomi che sempre
lo inseguiamo. È il lavoro – il lavoro che va
da una parte all’altra, senza dirci niente.
Vorrei che andassimo assieme nel luogo dove il Bounty
condusse uno scampolo di umanità. Si chiama Pitcairn,
ed è solo una voglia tra le scapole dell’Oceano Pacifico.
Potremo starcene su quell’isola per un po’, o per sempre.
La grigliata di pesce ti è sempre piaciuta parecchio
e hai sempre detto che la faccio bene.
Qualcuno dei nostri amici prima o poi ci raggiungerebbe,
di questo stanne certa. E allora saremmo
in buona compagnia – per attraversare il territorio
della vita. Il pomeriggio il cielo si stenderebbe come
una vela e noi ci schiacceremo nell’erba allo stesso modo
dei rospi che prendevi con il retino quando
eri bambina. Il mare farebbe i suoi esercizi
di stretching davanti ai nostri occhi e, dopo
essersi infranto, tornerebbe lo stesso di sempre.
La mansuetudine trarrebbe un nodo solo
dai lacci delle nostre scarpe e a quel modo
ci farebbe inciampare, ci ricorderebbe la vita
con un trascurabile dolore. Potremmo starcene laggiù,
quasi al di là di tutto, sarebbero anni più felici
che tristi. E di quel tuo pianto rimarrebbe l’estemporaneo
getto dell’ombra, una maschera qualche volta
affiorerebbe dai flutti, mutevoli, fuori
da questa baia, e sarebbe inafferrabile
per i becchi dei grandi rapaci oceanici.